|
Il documentario è stato realizzato nel 1967 dalla National Film Board of Canada
e fa parte di una nutrita serie di cortometraggi sugli Inuit pensati
dall’Educational Development Center del Canada; prodotto dal regista Quentin
Brown a da Kevin Smith, è stato originariamente suddiviso in due parti ma
seguire la costruzione del kayak senza interruzioni o intervalli rende più
piacevole ed istruttiva la visione: mentre nella prima parte l’occhio della
cinepresa di sofferma più sulle scene di vita domestica durante l’estate artica,
nella seconda parte segue con attenzione la progressione dei lavori sul kayak,
fino alla prova in acqua: “the man launch and test their new kayak and admire
its performance”!
 La
pellicola documenta la costruzione di un kayak da mare ad opera di due
cacciatori Inuit. La
pellicola documenta la costruzione di un kayak da mare ad opera di due
cacciatori Inuit.
E’ ambientato sulle sponde del mare ormai libero dai ghiacci nella bella
stagione estiva: il campo estivo, una tenda di pelli, una spiaggia di pietre,
una piccola famiglia composta da moglie e marito ed un figlio ancora piccolo ma
già in grado di stare in piedi... qualche oca all’orizzonte osservata con
cupidigia dai protagonisti, ma non c’è tempo per la caccia, occorre prima
terminare la costruzione del kayak.
La lentezza del vivere quotidiano segna anche il ritmo di lavoro e le poche
abitudini consolidate rendono ogni gesto magistrale; sembra di capire che
l’ospite anziano sia stato chiamato di proposito per assistere il cacciatore più
giovane nella difficile e raffinata arte di costruire un kayak da mare a mani
nude e con pochissimi strumenti di lavoro.
Le musiche sono del tutto assenti, non c’è colonna sonora, non c’è alcun suono
che accompagna il lavoro meticoloso della famiglia; si sentono solo di quando in
quando le voci raccolte in presa diretta dei protagonisti, i tre adulti che
parlano ed il piccolo irrequieto che ride, niente altro.
Colpisce subito l’uso del trapano manuale per realizzare i fori sulle centine:
un punteruolo di legno tenuto stretto tra le labbra, un archetto ed una
funicella che lo fa roteare velocemente... davvero ingegnoso!



Le centine vengono avvicinate e composte; piano piano si delinea la sagoma vuota
del kayak, prima l’alzata del ponte anteriore, poi lo scafo ed infine i ponti
superiori: incanta il lavoro certosino per ricavare le centine dalle assi di
legno grezzo, le pietre della spiaggia usate come cunei, si sceglie quella di
misura più adatta, pochi attrezzi, tutti naturali e sempre a portata di mano!
La moglie del cacciatore, intanto, prepara le pelli ed il suo labbro inferiore
tradisce una vita trascorsa a conciare le pelli con i denti e la saliva; la
donna pulisce le pelli con il raschietto a mezzaluna, manico di legno a forma di
oliva ed estremità arrotondata di ferro o di osso; poi le porta al torrente di
acqua dolce e ghiacciata e le ammorbidisce facendole affondare sotto grandi
ciottoli; infine, torna a pulirle, togliendo anche le ultime tracce di pelo di
foca.
Le cime per fissare le centine sono ottenute dalle pelli, tagliando delle
striscioline dai bordi esterni; chissà come riescono a ricavare le cime più
resistenti di tendini di foca... quelli che vengono intrecciati tutt’intorno
alla struttura interna del kayak per tenere insieme tutte le sue parti.
Le centine vengono poi scaldate: immerse nel pentolone di sangue di foca che
ribolle sul fuoco, sono lavorate con i denti, piegate leggermente di volta in
volta finché non assumono la forma di tutte le altre.
L’ultima attenzione per il pozzetto, non una misura standard ma calibrata sulla
morfologia di ogni cacciatore e forse anche sull’ingombro delle pellicce
indossate, incredibilmente calde ma inevitabilmente gonfie.
Finalmente è la volta delle pelli di foca cucite ad arte sullo scafo e
tutt’intorno al kayak: i gesti sono antichi e sapienti, pochi passaggi di ago di
avorio e la sagoma del kayak che magicamente si riempie.
Secondo gli antichi riti sciamanici, occorre sistemare a prua un piccolo
portafortuna, per allontanare gli spiriti malvagi o per scongiurare le cattive
intenzioni di qualche altro cacciatore, un portafortuna come quello in legno che
adesso orna le cime del ponete anteriore, forse un piccolo orso o un grande
tricheco.

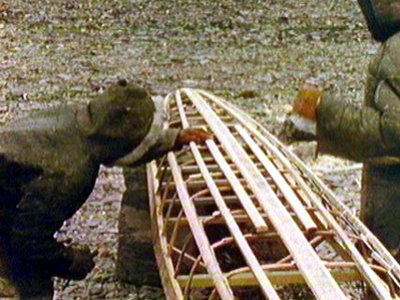

Il varo del kayak è preceduto dalla sistemazione del sedile: una pelliccia
bianca e morbida adagiata sul fondo del pozzetto, null’altro occorre per rendere
confortevole la navigazione nelle fredde acque artiche.
La prova in acqua sembra spaventosa, l’equilibrio estremamente precario ed il
pozzetto altissimo… per non dire della pagaia, che sembra un tronco dal manico
così largo che pare affondare... forse è ancora grezza, finiranno di lavorarla
in un secondo momento, magari al caldo della tenda...
La caccia al salmone occupa un momento di “riposo” della giornata e viene
effettuata con un arpione dalla punta mobile per assecondare i movimenti
inconsulti dei pesci appena catturati; la pausa dal lavoro si protrae durante il
pranzo, allestito in maniera informale dopo aver preparato il pesce con la
solita mezzaluna, l’ulu, un attrezzo utilizzato dalle donne per qualsiasi lavoro
domestico.
I tre protagonisti del documentario non guardano mai in macchina, salvo il
bambino, e sembrano totalmente assorti nel loro lavoro, chiacchierano fitto e
talvolta ridono di gusto, per ragione a noi incomprensibili!
Il bambino, invece, si annoia visibilmente, ma gioca instancabilmente: gioca a
nascondino con la cinepresa nelle prime scene del documentario, gioca ad
impilare le pietre piatte della spiaggia (un antesignano del rock balancing
moderno?), gioca a stare in equilibrio su un tronco con la pagaia in pugno; poi
si inventa un gioco più macabro: rianimare un gabbiano morto; e non smette mai
di disturbare i genitori, mordendo il cappuccio del padre o scalando la schiena
della madre, che lo lascia fare e poi lo bacia sfiorandogli in naso.
Quando il lavoro è terminato, ed il kayak viene adagiato sul pelo dell’acqua,
allora si può finalmente andare a caccia!
|