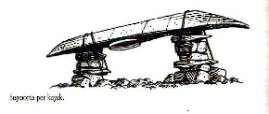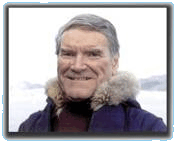|
Il bellissimo libro di James Houston, dedicato “agli Inuit e agli altri amici
dell’Artico”, è stato tradotto in italiano da Franca Genta Bonelli e pubblicato
dalla casa editrice Piemme in una prima edizione del 1998 dal titolo fedele
all’originale inglese “Confessioni di un abitatore di igloo”, accompagnato da un
lungo sottotitolo esplicativo: “1948-1963: miti e leggende del popolo dei
ghiacci quando ancora la civiltà degli eschimesi viveva le sue antiche
tradizioni”.
Mi è piaciuto talmente tanto che mi sono affrettata a comperare anche un secondo
volume dello stesso autore dal titolo analogo, “Alla scoperta degli Inuit – Vita
quotidiana con gli eschimesi”, sempre tradotto in italiano da Franca Genta
Bonelli e sempre pubblicato dalla casa editrice Piemme in una seconda edizione
del 1999 con un sottotitolo altrettanto lungo: “quindici anni di vita nel Grande
Nord, terra di ghiacci incontaminati dove la luna è ancora un Dio e i cani da
slitta parlano solo con i bambini”...
Curioso, quante similitudini, ho pensato subito, ma presa dal gusto della
lettura già pregustavo il piacere di immergermi in un’altra opera omnia sugli
Inuit, e quasi non volevo credere all’evidenza quando ho scoperto che si
trattava dello stesso identico libro!!!
Non commettete lo stesso errore, ma non commettere neanche l’errore di non
leggerlo!
  Bellissimo,
l’ho già detto! Bellissimo,
l’ho già detto!
Houston ha saputo ascoltare, ricordare e riportare le leggende, le credenze e le
storie di uno straordinario popolo all’epoca ancora padrone dell’Artico
incontaminato e con un centinaio di episodi apparentemente scollegati ha saputo
tratteggiare le abitudini degli Inuit: ogni racconto è ricco di novità e di
scoperte; ogni personaggio è carico di fascino e seduzione; ogni viaggio è pieno
di avventura e di pericoli. Houston ha vissuto molti anni tra gli Inuit nel
tentativo di incrementare le loro attività artistiche ed artigianali, convinto
sostenitore che della teoria che l’arte avrebbe garantito loro una vita
altrettanto dignitosa della caccia e della pesca.
Houston scopre gli Inuit un poco alla volta, senza alcuna presunzione,
consapevole dei limiti dell’uomo bianco, sedotto dal loro spirito pacifico e
dalla loro incapacità di recar danno alla natura e soprattutto ammirato dalla
loro curiosità per il nuovo ed il diverso.
Houston racconta dello loro impazienza di stringere mani, dei loro ampi sorrisi,
del loro modo amichevole di ridere, delle loro rauche voci cantilenanti, della
loro visione allegra e fatalistica della vita e della morte, della somiglianza
di alcuni cacciatori con “una robusta palla da football americano di cuoio
scuro”, della loro abitudine di entrare in casa senza mai bussare alla porta,
della loro abilità primitiva nella caccia (“loro sanno esattamente quando è il
momento di sparare, noi no!”), della loro maestria nella lavorazione delle pelli
per renderle impermeabili, della loro incapacità di operare in un’economia
basata sul denaro, della loro cultura della divisione con gli altri “per cui
persone che vivono ad un giorno di viaggio si considerano amici intimi e
desiderano condividere tutto”, della loro incapacità di giocare a calcio perché
non sono competitivi e non sanno riconoscere nell’altro un avversario, della
strabiliante ingegnosità che permette loro di costruire denti nuovi ricavandoli
dall’avorio di tricheco o di migliorare una gamba di legno con le corna di bue
muschiato per non cadere nella neve di primavera o di scolpire nell’osso parti
di motore fuoribordo per sostituire un pezzo rotto o di traghettare uova su un
fiordo tra i ghiacci scolpendo nel ghiaccio una piccola barca con la prua
appuntita (“spero che gli Inuit vorranno studiare ingegneria, architettura,
progettazione navale o rilevamento geografico: sono tutte materie che li hanno
vivamente interessati e per le quali sembrano avere una predisposizione
naturale”).



Lancia per i pesci
Ulu
Lenza da donna
Entra nei particolari: le lunghe code di pelliccia dei parka indossati dalle
donne per sedersi comodamente su sassi o neve, la temperatura interna dell’igloo
mantenuta sotto il punto di congelamento per evitare nebbia o addirittura
pioggia al suo interno, l’alimentazione a base di carne, pesce e uova senza mai
poter mangiare né frutta né verdura, l’abitudine di bere caffè leggero e te di
foglie bollito fino a farlo diventare nero, le tombe costruite sullo strato di
muschio della tundra con pietre pesanti per tenere lontani gli animali ed
impedire al corpo di andarsene in giro a terrorizzare persone e cani, il cordone
ombelicale dei neonati reciso in modo netto con i denti, il nome dato al bambino
solo quando si poteva ragionevolmente credere che sarebbe sopravvissuto, il
doppio nome imposto dal governo canadese, le vecchie abitazioni dei cacciatori
di balene mezze tende e mezzi igloo con una bassa porta di legno rosso, gli
igloo di ghiaccio costruiti durante la caccia ma sostituiti appena possibile
dagli igloo di neve più caldi (!) e confortevoli, l’usanza di fermare la slitta
prima di raggiungere un accampamento per rimettersi in ordine, liberarsi della
neve e del ghiaccio e sostituire gli abiti con quelli puliti in modo da entrare
nel campo con una parvenza di buona forma, i cani che non vengono mai legati
perché hanno bisogno delle mani che li nutrono, i gas di scarico delle prime
motoslitte meno “pesanti” delle emissioni gassose di una muta di cani nutrita
con carne di tricheco, le mute legate a ventaglio alle slitte per lasciare i
cani liberi di trovare separatamente il percorso migliore tra le crepe del
ghiaccio (“quando viaggiate insieme agli Inuit con una slitta trainata da cani è
bene lasciare le decisioni interamente a loro perché sanno tutto quanto riguarda
ciò che stanno facendo in questo loro strano e duro mondo, e voi no”).
Svela i segreti del mondo Inuit: il gesto intimo di pettinare i capelli delle
donne, lo stare seduti con le gambe distese in avanti, le mani morbide e calde
perché sempre protette dal freddo con le muffole, l’arte della seduzione
femminile che consiste semplicemente nel camminare, l’antica usanza dello
scambio delle mogli svolto nella piena consapevolezza di tutte le persone
coinvolte (“così non c’è nulla di segreto”), l’amuleto di coltellini d’avorio
legati insieme per aiutare a “tagliare il tempo”, la lanterna ad olio accesa per
tutto l’inverno perché non si fidano del buio, i canti invernali cantati da una
giovane donna direttamente nella gola di un’altra per creare un suono
completamente nuovo, il soffitto a volta dell’igloo scintillante di milioni di
cristalli di ghiaccio che brillano alla luce della candela, le regole di bon ton
che impongono di mangiare la carne cruda senza mai strappare via l’osso per
rosicchiarlo coi denti “come noi barbari che viviamo nel sud facciamo talvolta
con le cosce di pollo”, la convinzione che gli animali abbiano il potere di
ascoltare e di capire gli esseri umani, la credenza che gli orsi possano
togliersi la pelliccia come gli uomini fanno con il parka, i fucili considerati
strumenti non per la guerra o la difesa ma per procurare il cibo alla famiglia,
la buona educazione dei cacciatori che non si vantavano mai delle prede
catturate, l’usanza di lasciare una pala da neve sempre in posizione verticale
perché altrimenti si nasconderà (sommersa dalla neve!), la credenza che le donne
non potessero scolpire, cucire durante il lutto, mischiare carne e pesce,
cacciare le foche ma soltanto volpi, uccelli e ghiottoni.



Riporta con sorprendete ironia avventure e disavventure varie: la casa abitata
da Robert Flaherty, quell’irlandese che aveva girato la prima pellicola sugli
Inuit, “Nanook of the North”, che aveva trascinato lassù sia un pianoforte che
una vasca da bagno di lamiera laccata di verde con l’interno smaltato di bianco,
e che aveva una scala a pioli trasformata da lui stesso in scalini talmente
sconnessi da far sanguinare la testa a tutti gli ospiti, Houston compreso; la
stazione commerciale del 1950 costituita solo da un agente e da un missionario,
niente suola, niente infermeria, niente polizia, pochi igloo e tende invernali
impossibili da distinguere nel bianco della neve; le comunicazioni via radio con
gli insediamenti più lontani ed isolati che pur senza trasmettere notizie
permettevano di stabilire che tutti fossero vivi; la diffusione delle prime
malattie contagiose, la disperata corsa verso la salvezza delle moglie malata di
appendicite in un luogo lontano da raggiungere e difficile da lasciare, la
nausea provocata ai primi Inuit ricoverati in ospedale dal cibo occidentale che
non poteva competere col sapere della carne cruda; la diffidenza degli Inuit
verso i segnali stradali adottati nelle grandi città degli uomini bianchi,
perché anche con il semaforo rosso non potevano vedere gli occhi degli
automobilisti e capire cosa avessero intenzione di fare; il fallimentare
tentativo di trasferire in Quebec alcuni Lapponi Sami con le loro renne, che per
quanto addomesticate dagli uomini si dispersero nella tundra non appena furono
lasciate libere di seguire i caribù; l’esilarante racconto del viaggio nello
spazio dello Sputnik che nelle storie Inuit diventa “il giro intorno al mondo di
un cane di nome Laika che guida una slitta proiettile”.
Scrive molte parole nella lingua degli Inuit, l’Inuktitut: kitapik – poco,
taimak – abbastanza, illawak – molto, kakuktok – bianco, kouaklokasaktok – quasi
congelato, anowavingaluk – vento terribile, inua – anima, angakuk
– sciamano,
kallunat – uomo bianco, kallunait – donna bianca, kenouyutsat – carta moneta con
sopra una faccia, kiatok – stivali di pelle di foca, inuksuk – figure di pietra,
inuksuksalik – luogo delle figure di pietra, kunukai – il “naso” dell’igloo per
la ventilazione, mumungitok – non buono da mangiare, tuktut – caribù,
putik -
midollo di caribù, tukik – la luna, l’unico dio maschio che può mettere incinta
le donne nelle notti di luna piena, agalingwak – il narvalo, il cui unicorno si
è formato quando le trecce di una ragazza vennero attorcigliate per scherzo da
due gabbiani, Saomik – mancino ed Arnakotak - donna lunga (i nomi con cui i
coniugi Houston vennero adottati dalla famiglia Inuit del grande capo Pootoogook).
Soprattutto dedica un intero capitolo al kayak, quello regalatogli da una
vedova di un cacciatore, mancino come lui, restaurato dalle donne Inuit ed ora
conservato nel McCord Museum di Montreal, le pelli della coperta raschiate e
asciugate che si ritirano fino a diventare lisce come la pelle di un tamburo, il
bordo del pozzetto realizzato con un robusto pezzo di legno inzuppato nell’acqua
ed esposto al vapore per riuscire a piegarlo coi denti e fargli assumere una
forma ovale, il tutto tenuto insieme con legacci di pelle di foca in modo tale
che durante gli uragani il kayak possa distendersi secondo le onde invece di
spezzarsi, l’accortezza di salire a bordo senza la minima quantità di sabbia
sugli stivali perché i granelli potrebbero raschiare e bucare la pelle, il
“segreto” di pagaiare senza sforzo facendo rotolare la pagaia sopra un pezzo di
grasso di foca sul bordo del pozzetto “per far riposare le braccia nei viaggi
lunghi”.
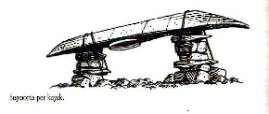
Houston dissemina nel suo romanzo capitoli preziosi sulla costruzione dell’igloo
(11), sull’utilizzo delle slitte (18), sui miti Inuit (26), sulle figure di
pietra costruite forse per occupare il tempo forse per segnare la strada (32),
sulle faticose procedure di matrimonio (52), ma anche racconti divertenti sul
trasporto di una casa in legno che coinvolge l’intero villaggio oppure diari
struggenti sul terribile destino di una famiglia divisa dalla tubercolosi o
ancora tanti, tantissimi spunti di riflessione sulla contaminazione,
modernizzazione, evoluzione del popolo Inuit.
Le 370 pagine del libro sono piene di racconti appassionati che richiamano scene
di film famosi: la piccola slitta trainata da un cucciolo per allenare i bambini
al comando (come in “Nanook of the north”), i canti rituali accompagnati dal
suono ritmico del tamburo di pelle di foca (come in “Le nozze di Palo”), la
tecnica di caccia della molla di osso nascosta nella polpetta di carne
ghiacciata (come in “Ombre Bianche”), la sapiente scelta degli amuleti per
proteggersi dagli spiriti malvagi (come in “Atanarjuat”), la prodigiosa capacità
dei cacciatori di attendere la preda sulla tana senza mai muoversi per ore ed
ore (come in “The fast runner”).
Un libro da leggere, studiare, sottolineare, rileggere e conservare: una fonte
inesauribile di informazioni sul popolo Inuit, sulle sue storie passate e sulle
sue prospettive future.
James Houston è stato un artista ed uno scrittore canadese di origini
scozzesi; nato a Toronto nel 1921, dopo la seconda guerra mondiale decide di
trascorrere 12 anni tra gli Inuit del Quebec; durante il suo soggiorno a Capo
Dorset, dove vive con la moglie Allie e con i due figli John e Sam secondo lo
stile locale Inuit, viene nominato dapprima Responsabile degli Affari del Nord e
poi primo amministratore della parte occidentale dell’Isola di Baffin, una
carica pensate su misura per lui, che così arriva a cumulare nella sua persona
diverse cariche: responsabile delle richieste minerarie, degli esplosivi, delle
pellicce, della selvaggina, della pesca e dei cani. Spesso deve accompagnare
nell’interno per conto del governo i primi esploratori, qualche cacciatore, le
prime delegazioni di scienziati ed i primi gruppi di turisti danarosi.
Considerato come colui che per primo ha dato inizio allo sviluppo dell’arte
Inuit, è stato Presidente sia dell’American Indian Arts Centre che del
Canadian Eskimo Arts Council, oltre che direttore della Associazione per gli
Affari degli Indiani d’America. E’ stato insignito del Premio della Fondazione
Culturale degli Indiani d’America e degli Inuit, del Premio al Merito degli
Inuit Kawati nel 1979 ed è membro dell’Order of Canada.
Nei primi anni 50, in cambio di alcuni ritratti disegnati a matita sui fogli del
suo inseparabile album, Houston riceve le prime piccole sculture Inuit da uomini
imbarazzati e riconoscenti; prende così contatti con la Build of Craft
(l’Associazione Canadese dell’Artigianato fondata sul finire dell’Ottocento), la
più antica e rispettata organizzazione senza scopo di lucro di tutto il Canada
ed ottiene di aprire una linea di credito con gli scultoti Inuit attraverso la
Compagnia della Baia di Hudson, fino al 1939 dedita esclusivamente al commercio
di pellami, per poi crea la Eskimo Art Inc. al fine di sdoganare le opere d’arte
dal Canada verso Stati Uniti ed Europa.
Con perseveranza, pazienza e preveggenza, Houston comincia a raccogliere
sculture Inuit tra i cacciatori che incontra nei suoi spostamenti in aereo, in
slitta o in barca; la prima volta offre in cambio un paio di occhialoni militari
dalle lenti regolabili progettati per i piloti che dovevano riconoscere i caccia
nemici anche contro sole; poi offre i buoni della Compagnia ed infine trasforma
il baratto in commercio vero e proprio, nella convinzione che l’arte avrebbe
potuto sopperire alle caccia per assicurare la sopravvivenza a quel popolo
straordinario.
Organizza mostre itineranti nei villaggi Inuit ed in Canada, concentra la sua
attenzione su statuette e disegni, su lavori di cucito e decorazioni,
applicazioni di pelle e dipinti a mascheramento, fino ad ideare, progettare e
realizzare nel 1957 un laboratorio Inuit di stampe e litografie, modulando gli
studi giapponesi e adattando le tecniche alle risorse locali: non legno ma
steatite a grana fine e corna di caribù (mai avorio!)
Houston sapeva bene che quelle sculture e quei disegni avevano assorbito
l’eredità artistica della millenaria cultura Inuit (Dorset del 2500 a.C. e Thule
del 1000 d.C..), quando la necessità di realizzare amuleti sciamanici in avorio,
corno, pietra o legno rispondeva al bisogno di rendere propizia la caccia
all’orso, figura simbolo dell’arte Inuit insieme alla dea del mare, metà donna e
metà foca, scolpita in denti di tricheco o in osso di balena, abbandonate in
grandi quantità sulle spiagge quando la scoperta del petrolio aveva ormai
soppiantato il commercio dei balenieri; sapeva anche che ogni scultore Inuit
cercava in tutti i modi di essere originale, di trasporre nelle sue opere
l’atavica abilità di osservare uomini ed animali e di catturare l’essenza dei
loro movimenti; gli Inuit sono sempre stati esperti di anatomia e hanno sempre
isolato le immagini nello spazio senza creare regole di prospettiva, “sono forse
gli spiriti liberi più ingegnosi e industriosi del mondo”.
L’arte Inuit viene ora gelosamente conservata ed esposta nelle collezioni di
vari musei del mondo (Art Gallery of Ontario, Art Gallery of Winnipeg, British
Museum di Chicago) perché ha mantenuto “l’abilità di parlarci attraverso grandi
distanze di linguaggio e di tempo”, sebbene gli Inuit non abbiano mai avuto una
parola per indicare l’arte, ma solo un termine vago per la scultura “sinunguak”
(letteralmente una piccola cosa fatta da voi) oppure l’incisione “titoraktok”
(cioè segni fatti dalla vostra mano).

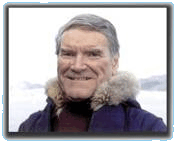
James Houston spedisce una scultura Inuit
Ottawa 1951 James Houston (1921-2005)
|

 Bellissimo,
l’ho già detto!
Bellissimo,
l’ho già detto!