|
Il sottotitolo in copertina è chiaro: lo straordinario racconto filosofico di un
viaggio con il padre alla ricerca del Tempo. Ma non dice tutto. L’autore
accompagna al Polo Nord il padre ottantenne che mai si è mosso dal suo paesino
di campagna e quello che sembra un viaggio di famiglia diventa insieme lo spunto
per una amara riflessione sulla condizione degli Inuit.
L’autore giunge infatti a conclusioni tutt’altro che confortanti.
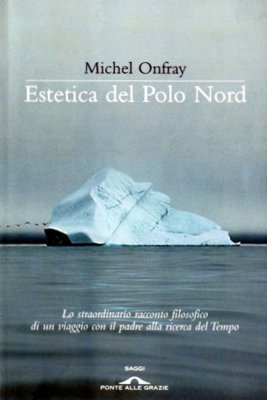 Da
principio, cerca il tempo geologico guardando le pietre che dappertutto dominano
il Polo, le pietre con cui gli Inuit costruiscono gli Inukshuk, gli omini
disseminati lungo i percorsi di caccia: “con queste pietre intelligenti
fabbricate utilizzando pietre grezze, il tempo geologico diventa tempo
geografico”. Sperimenta il tempo climatico sulla propria pelle, tremando dal
freddo quando le temperature scendono sotto lo zero: “la temperatura polare è
disumana, nel senso etimologico”. Poi studia il tempo esteso dello spazio,
quelle enormi distese bianche che mettono l’uomo di fronte alle sue paure
ancestrali: “Il romanticismo incombe non appena ci si trova soli di fronte alla
smisurata immensità delle montagne, delle scogliere, dei torrenti...” Da
principio, cerca il tempo geologico guardando le pietre che dappertutto dominano
il Polo, le pietre con cui gli Inuit costruiscono gli Inukshuk, gli omini
disseminati lungo i percorsi di caccia: “con queste pietre intelligenti
fabbricate utilizzando pietre grezze, il tempo geologico diventa tempo
geografico”. Sperimenta il tempo climatico sulla propria pelle, tremando dal
freddo quando le temperature scendono sotto lo zero: “la temperatura polare è
disumana, nel senso etimologico”. Poi studia il tempo esteso dello spazio,
quelle enormi distese bianche che mettono l’uomo di fronte alle sue paure
ancestrali: “Il romanticismo incombe non appena ci si trova soli di fronte alla
smisurata immensità delle montagne, delle scogliere, dei torrenti...”
Questo è quanto racconta nella prima parte, dedicata al tempo elementare: la
rarità.
Poi passa al racconto del viaggio e nella seconda parte si dedica al tempo
vissuto: l’immobilità.
Così ragiona sul tempo vitale parlando delle necessità elementari, della lotta
per la sopravvivenza degli Inuit, la loro battaglia quotidiana contro le
condizioni ambientali avverse, la ricerca del cibo, la caccia. E anche sul tempo
irrigidito della ripetizione, puntando il dito contro il passaggio dalla
tradizione orale alla scrittura, il primo passo verso la dominazione della
cultura Inuit: “la scrittura trasforma la parola viva in lingua morta”. E si
consola pensando al tempo dissimulato del rito, alla capacità che hanno
conservato gli Inuit di tacere tutta la loro lettura tradizionale, rituale e
sciamanica della vita: si difendono restando in silenzio, ma forse il silenzio
non riuscirà a salvarli.
E scendendo lungo la china pericolosa della riflessione filosofica sul futuro di
un popolo tormentato, l’autore espone nella terza parte del volume la sua
visione pessimistica del mondo: il tempo distrutto della scomparsa.
E’ così la volta del tempo allogeno della colonizzazione, quando arriva il
momento di incontrarsi e conoscersi, ma i primi visitatori non danno prova di
empatia e ben presto il pregiudizio occidentale che voleva gli Inuit rozzi e
arretrati diventa autoritarismo coloniale, con la tirannia degli orari e la
dittatura degli impieghi del tempo: “essere in un luogo preciso in un tempo
preciso per un’attività precisa, ecco che cosa permette un controllo totale ed
una padronanza assoluta dei corpi, delle anime e delle energie”. E ancora del
tempo rubato, della sedentarietà divenuta regola, del nomadismo dimenticato,
della costrizione a vivere nello stesso luogo senza poter levare le tende ad
ogni cambio di stagione.
Un passo su tutti merita di essere riportato per esteso: “Anche gli Inuit hanno
subito la legge dell’impero americano, l’odio dei radicati per coloro che
viaggiano e dispongono a proprio piacimento della geografia, regolandosi solo
sulla natura e rispettando solo le proprie leggi. Il loro torto? Agire e
muoversi a seconda del cielo e della neve, della consistenza del ghiaccio o
dell’altezza del sole nel cielo. La loro colpa? Preferire le lezioni della
stella polare e le indicazioni delle costellazioni a quelle del centralismo
burocratico. La loro arroganza? Ignorare la Legge, la falsa uguaglianza
repubblicana e preferire l'indipendenza, la libertà, l’autoregolazione,
l’insubordinazione della tribù alla regola generale. La loro pena?
L’umiliazione, la cancellazione dei loro costumi, la fine del nomadismo: la
sedentarietà obbligatoria, la casa in piedi. Prigione e decadenza”.
 E
non è finita qui. Il filosofo è molto risentito con la cultura occidentale, con
la presunta superiorità dell’uomo bianco, con l’assurda omologazione dei bisogni
e delle aspirazioni. E
non è finita qui. Il filosofo è molto risentito con la cultura occidentale, con
la presunta superiorità dell’uomo bianco, con l’assurda omologazione dei bisogni
e delle aspirazioni.
Nell’ultimo capitolo sul tempo esaurito parla del nichilismo come unica arma
rimasta agli Inuit per difendersi dalla modernità incalzante. Ma è sufficiente
per combattere gli attacchi recenti? Cosa può mai fare l’Inuit contro il
bombardiere statunitense che il 21 gennaio 1968 si schianta contro la calotta
polare con quattro bombe termonucleari sotto le ali e di cui nessuno parla più,
nonostante abbiano preso fuoco gli esplosivi, i motori e la benzina dell’aereo e
l’acqua si è caricata di dosi mostruose di plutonio, uranio e tritio su un’area
di appena venti chilometri quadrati. Ed una quarta bomba si perde finendo in
fondo al mare...
L’eredità della guerra fredda la scontano al Polo Nord molti anni dopo la caduta
del Muro di Berlino.
Perché allora stupirsi di fronte ai suicidi dei giovani Inuit, alla sessualità
problematica, all’alcolismo dilagante, alla violenza crescente nelle piccole
comunità, all’ansia, all’angoscia?
“Il conflitto tra il tempo allogeno ed il tempo indigeno produce questo tempo
nichilista: niente ha valore, non ci sono più valori”.
Al Polo Nord nessuno ha più voglia di assomigliare ad un antenato, di rischiare
la vita per della carne di foca quando il sussidio statale assicura vestiti,
pane e birra tutti i giorni; non si può biasimare un cacciatore “che ha
praticato il kayak e oggi sta attaccato ai comandi dei suoi battelli
equipaggiati di GPS, schermi al quarzo liquido e strumenti di navigazione”.
Perché fare fatica se si può vivere all’occidentale?
Ma conviene davvero vivere alla maniera occidentale? Dimenticare il tempo a
favore del denaro? Trascurare i bisogni essenziali del mangiare, bere, dormire e
sognare per rincorrere bisogni indotti di ricchezza, fama, lusso e apparenza?
Forse ho imparato fin troppo bene la lezione del filosofo francese o forse ci
culliamo entrambi nell’illusione che l’umanità ha ancora un’ultima possibilità
di tornare sulla retta via... Chissà.
Intanto, il padre che aveva suggerito all’autore il viaggio al Polo è mancato
poco tempo dopo e l’edizione italiana del volume riporta, oltre alle foto
scattate nel Grande Nord, anche il toccante elogio pronunciato dal figlio alla
cerimonia funebre del dicembre 2009.
Un libro da leggere tutto d’un fiato: e poi correre fuori a pagaiare per un
giorno intero!

Michel Onfray è un filosofo francese che ha raggiunto la fama internazionale
con la pubblicazione di un fortunato quanto discusso “Trattato di ateologia”.
Nato da una famiglia di contadini normanni, consegue la laurea in Filosofia e
dopo aver insegnato per qualche anno al liceo, fonda l’Université populaire de
Caen. Wikipedia spiega che “grazie ad un linguaggio ricco e fluente, riesce a
spiegare efficacemente le sue teorie nel corso di trasmissioni televisive o
radiofoniche. Non sorprende quindi che anche emittenti di stampo conservatore lo
invitino sovente, perché egli ricopre il ruolo di "ateo di servizio" (athée de
service, secondo una definizione da lui coniata)”. Ricco di informazioni il suo
sito web: http://www.michelonfray.fr. |
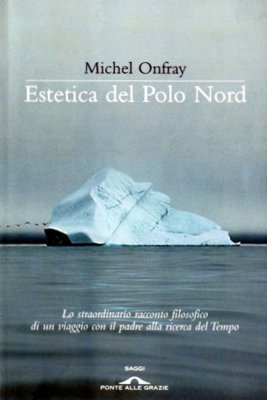 Da
principio, cerca il tempo geologico guardando le pietre che dappertutto dominano
il Polo, le pietre con cui gli Inuit costruiscono gli Inukshuk, gli omini
disseminati lungo i percorsi di caccia: “con queste pietre intelligenti
fabbricate utilizzando pietre grezze, il tempo geologico diventa tempo
geografico”. Sperimenta il tempo climatico sulla propria pelle, tremando dal
freddo quando le temperature scendono sotto lo zero: “la temperatura polare è
disumana, nel senso etimologico”. Poi studia il tempo esteso dello spazio,
quelle enormi distese bianche che mettono l’uomo di fronte alle sue paure
ancestrali: “Il romanticismo incombe non appena ci si trova soli di fronte alla
smisurata immensità delle montagne, delle scogliere, dei torrenti...”
Da
principio, cerca il tempo geologico guardando le pietre che dappertutto dominano
il Polo, le pietre con cui gli Inuit costruiscono gli Inukshuk, gli omini
disseminati lungo i percorsi di caccia: “con queste pietre intelligenti
fabbricate utilizzando pietre grezze, il tempo geologico diventa tempo
geografico”. Sperimenta il tempo climatico sulla propria pelle, tremando dal
freddo quando le temperature scendono sotto lo zero: “la temperatura polare è
disumana, nel senso etimologico”. Poi studia il tempo esteso dello spazio,
quelle enormi distese bianche che mettono l’uomo di fronte alle sue paure
ancestrali: “Il romanticismo incombe non appena ci si trova soli di fronte alla
smisurata immensità delle montagne, delle scogliere, dei torrenti...” E
non è finita qui. Il filosofo è molto risentito con la cultura occidentale, con
la presunta superiorità dell’uomo bianco, con l’assurda omologazione dei bisogni
e delle aspirazioni.
E
non è finita qui. Il filosofo è molto risentito con la cultura occidentale, con
la presunta superiorità dell’uomo bianco, con l’assurda omologazione dei bisogni
e delle aspirazioni.